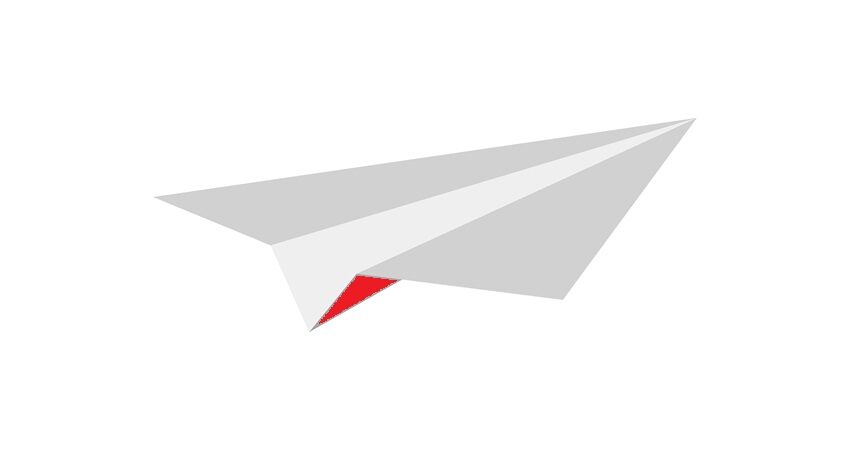Nature restoration law: manca la visione intersezionale
Il 24 giugno 2024, dopo un lungo iter legislativo, è stato adottato il Regolamento (UE) 2024/1991 for a regulation on nature restoration, in vigore dal 18 agosto 2024.
Il regolamento si inserisce nella strategia UE sulla biodiversità, uno dei pilastri del Green New Deal. Una delle novità del testo è l’obbligo di “ripristino” della natura. L’art. 3 definisce la restoration come «the process of actively or passively assisting the recovery of an ecosystem in order to improve its structure and functions, with the aim of conserving or enhancing biodiversity and ecosystem resilience, through improving an area of a habitat type to good condition, re-establishing favourable reference area, and improving a habitat of a species to sufficient quality and quantity […]».
La pagina ufficiale del Consiglio Europeo presenta l’atto in sintesi e sottolinea i “benefici” del buono stato degli ecosistemi per l’umanità. È interessante rilevare come tra i benefici di un buono stato ecologico non sia presente alcun riferimento alla riduzione delle discriminazioni e delle diseguaglianze socio-economiche.
L’unica intersezione tra tutela della natura e diritti umani presente nel testo è contenuta nel considerando n. 4. Esso richiama l’obiettivo 1 del Quadro globale in materia di biodiversità, adottato in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica del 2022. L’obiettivo 1 consiste nel garantire che «tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare; portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni».
Come è noto le popolazioni indigene sono riconosciute in una pluralità di atti internazionali ed europei come soggetti che subiscono discriminazioni ambientali. Tuttavia, tale richiamo appare scarsamente utile a garantire una visione autenticamente intersezionale, che tenga conto della indubbia connessione tra tutela dell’ambiente e tutela dei diritti umani, compreso il diritto a non subire discriminazioni.
Se è vero che «nature is the foundation of the world’s economy», stupisce che non vi sia in tale atto alcun riferimento all’esigenza di una just transition, ossia il processo verso la neutralità climatica che sia in grado di garantire stabilità occupazionale; sostenibilità ambientale ed eguaglianza economica.
Il regolamento avrebbe potuto meglio sviluppare i numerosi richiami in esso contenuti alla resilienza. Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio del 2020 Strategic Foresight Report Strategic Foresight – Charting The Course Towards A More Resilient Europe (COM/2020/493 final), la resilienza è, infatti, definita come «la capacità non solo di resistere alle sfide e farvi fronte ma anche di attraversare le transizioni in modo sostenibile, giusto e democratico». La definizione di un quadro normativo che garantisca la resilienza e il ripristino degli ecosistemi dovrebbe, in altre parole, così come previsto, ad esempio, nell’Accordo di Parigi, «rispettare, promuovere e prendere in considerazione gli obblighi degli Stati nei confronti dei diritti umani, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all’eguaglianza di genere, all’emancipazione delle donne e all’equità intergenerazionale».